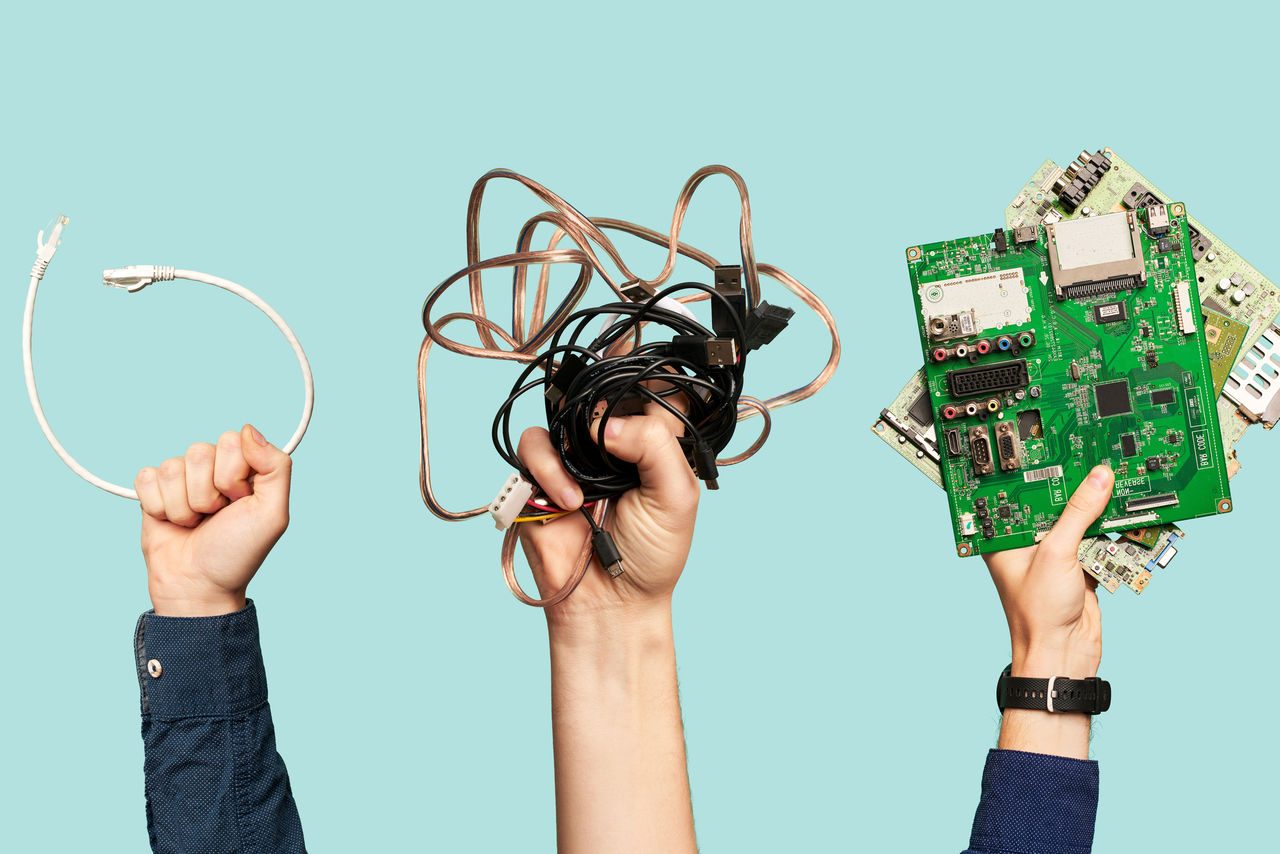Dal 2021 questa scala si applica alle seguenti categorie di prodotti: frigoriferi per uso domestico/alberghiero, frigoriferi per uso commerciale, lavastoviglie, lavatrici, televisori, schermi e display, lampade e lampadine.
Anche smartphone e tablet - analogamente a quanto già avviene per gli elettrodomestici - verranno classificati con lettere (da A a G, dove A è il massimo dell’efficienza) e colori, così da rendere le informazioni leggibili a colpo d’occhio. Inoltre, l’etichetta includerà una serie di indicatori chiave: dall’efficienza energetica alla durata della batteria, dalla riparabilità alla capacità di resistere alle cadute fino agli aggiornamenti software. In questo modo, l’utente sarà in grado di capire immediatamente se uno smartphone consuma meno energia, se potrà essere riparato facilmente o se avrà una batteria longeva.
Andando ad analizzare nel dettaglio, l’etichetta energetica dei dispositivi mobili sarà composta da una serie di indicatori pensati per offrire una panoramica chiara e completa sulle prestazioni tecniche e ambientali di ogni modello. Al primo sguardo, oltre al marchio e al codice identificativo del prodotto, elementi essenziali per tracciabilità e riconoscibilità, spiccherà la classe di efficienza energetica, ossia la scala cromatica e alfabetica.
Subito sotto, l’etichetta riporterà la durata della batteria in condizioni di uso intensivo, espressa in ore e minuti: questo consente di capire immediatamente quanto un dispositivo potrà effettivamente durare durante l’uso quotidiano, al di là delle promesse commerciali. Un altro indicatore fondamentale riguarda la durata della batteria in termini di cicli di ricarica: l’etichetta specificherà il numero di cicli completi prima che la capacità si riduca all’80% di quella originale. Il minimo richiesto è di 800 cicli per gli smartphone, ma alcuni modelli più avanzati potrebbero arrivare a superare i 1.000 cicli.
Tra gli altri parametri visibili, spiccherà anche la classe di resistenza agli urti, che valuta la robustezza fisica dei dispositivi. Uno degli elementi più rilevanti, però, è l’indice di riparabilità, espresso con un punteggio da 0 a 10. Questo valore deriva da sei fattori ponderati: semplicità di smontaggio, tipologia dei fissaggi, strumenti richiesti, disponibilità di pezzi di ricambio, durata minima del supporto software, accessibilità delle guide di riparazione. Inoltre, la normativa penalizza i produttori che inseriscono blocchi software in grado di ostacolare la sostituzione delle componenti. L’obiettivo è rendere ogni dispositivo riparabile anche al di fuori dei circuiti ufficiali, favorendo il riutilizzo e riducendo la produzione di rifiuti elettronici. Completa il quadro l’indicazione del grado di protezione da polvere e liquidi: la certificazione sarà valida solo se ottenuta senza l’uso di custodie protettive. Ogni etichetta includerà inoltre un codice QR, che rimanderà a un database europeo contenente tutte le informazioni tecniche, i risultati dei test, la documentazione completa del modello e i riferimenti normativi.
Oltre alla parte visibile al consumatore, l’introduzione dell’etichetta comporta obblighi vincolanti per i produttori: dovranno garantire la fornitura di pezzi di ricambio e aggiornamenti software gratuiti per almeno cinque anni. I test tecnici dovranno seguire protocolli standardizzati, e sarà vietata qualsiasi modifica software durante le prove di laboratorio. La verifica dell’attuazione sarà responsabilità degli Stati membri, ma in Italia non è stato ancora designato ufficialmente l’ente incaricato del controllo.
Secondo i calcoli dell’Unione Europea questa nuova normativa porterà a un risparmio di circa 20 miliardi di euro da qui al 2030 (-24% rispetto allo scenario base) principalmente grazie alla maggiore longevità dei dispositivi che allungherà i tempi di acquisto di un nuovo smartphone. Nello stesso periodo di riferimento sono previsti costi di riparazione maggiori (800 milioni di euro) e tagli sulle bollette per la ricarica (-600 milioni di euro).